
La rigenerazione sarà minuta, parola di Elena Granata
A colloquio con l’architetta, docente di urbanistica, scrittrice e membro della commissione Sherpa del Consiglio dei Ministri. «La città del quarto d’ora? Risveglia il sogno della comunità».
Mi ha fatto molto piacere sapere della nomina di Lesley Lokko a curatrice della Biennale di Architettura di Venezia, per tre motivi. Il primo è che è una donna di un’identità multiculturale, metà africana metà anglosassone. La seconda buona notizia è che è una donna ed è un’architetta: una rivoluzione nel mondo dell’architettura almeno dai tempi di Zaha Hadid. La terza che è una scrittrice di narrativa e a me questo piace molto, perché penso che oggi l’architettura, l’urbanistica, la storia di luoghi e città vadano raccontate in modo sempre più narrativo. C’è un pubblico molto curioso e interessato, non disciplinare, a cui possiamo arrivare con un linguaggio non immaginativo».
Elena Granata, architetta, docente di Urbanistica al Politecnico di Milano, anche lei scrittrice, commenta così la recente nomina di Lesley Lokko alla guida della Biennale 2023. Autrice di numerosi volumi, tra i quali Biodivercity, uscito per la collana Terrafutura di Giunti Editore con Slow Food, e il recentissimo Placemaker, pubblicato da Einaudi, la Granata è un’architetta ‘sui generis’, attenta ad un’architettura ‘piccola’, lontana dai grandi sviluppi immobiliari che sempre più sono diventati la cifra – come alcuni la definirebbero – della sua città, Milano. Ed è proprio sulla piccola scala, sul racconto di centri urbani come ecosistemi, che i suoi libri si focalizzano, dando spazio a storie di architetti visionari, urbanisti, ma anche designer, sindaci, imprenditori, psicologi, fino ai sacerdoti, ‘ribelli’ o placemaker – come li definisce nell’omonimo saggio – che contribuiscono attivamente alla costruzione di città più a misura d’uomo. Figure ibride, che mettono in crisi il ruolo tradizionale dell’architetto.
E a proposito della condizione letteraria dell’architettura, la Granata aggiunge «gli architetti hanno scritto poco, gli urbanisti ancor meno, se non i grandi, come Giancarlo De Carlo per fare un esempio. C’è pochissima tradizione. I miei libri non sono illustrati ma raccontati, perché ritengo che il valore comunicativo delle belle storie, storie di spazi, luoghi e persone, abbia un pubblico più ampio di quello a cui fino ad ora siamo arrivati. Abbiamo un mondo curiosissimo delle questioni che riguardano la casa, l’abitare lo spazio, la città, ma non c’è produzione letteraria. Questa è una delle ragioni per cui, penso, gli architetti sono sempre meno attori capaci di creare immaginari nelle persone, proprio perché non raccontano».
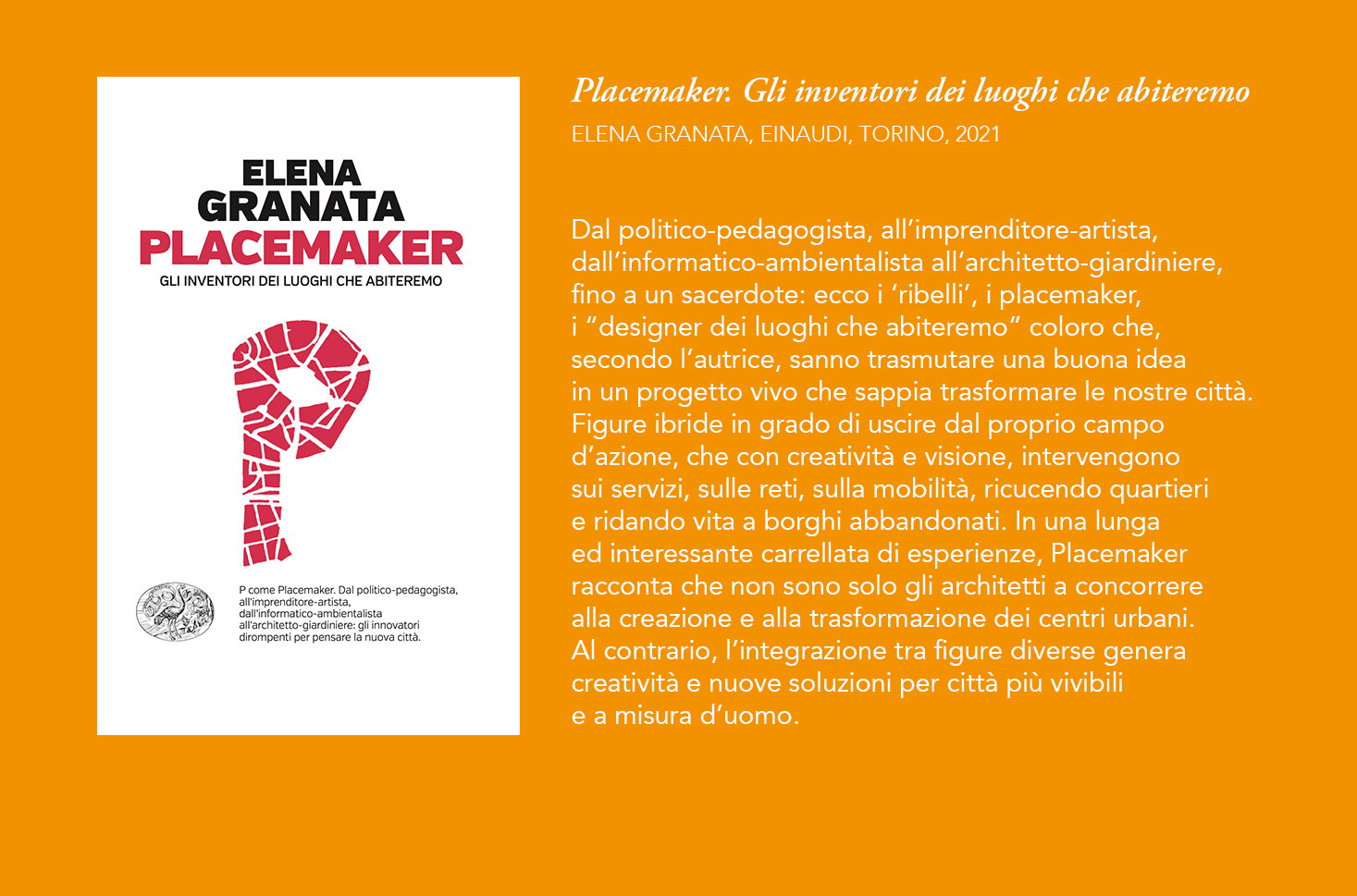
Scheda del libro Placemaker di Elena Granata
Dove si inseriscono i placemaker? Che cosa rimane dell’architetto, in questa visione?
Se ci guardiamo intorno, il mondo che una volta era popolato da architetti e tecnici, oggi è affollato da altre figure, quelle che racconto nel libro. E questa è una constatazione: basta vedere chi oggi si prende cura dei luoghi, chi li progetta. Sono recentemente stata contattata da Save the Children, per un progetto di rigenerazione di 10 spazi urbani per renderli aperti all’infanzia e ai giovani. Ecco, persino Save the Children si configura come placemaker! È vero quindi che c’è un affollamento positivo, dove c’è spazio per tutti – designer, preti, imprenditori, insegnanti.
Allora non c’è più spazio per l’architettura? Le scuole di architettura non servono più?
No, penso, e lo scrivo in Placemaker, che gli architetti, se capiscono che il loro campo d’azione è molto più ampio, più stimolante ed immateriale che nel passato, possono ritrovare un posto significativo. Materie come l’architettura, il design, il paesaggio si apprendono in queste scuole, ma serve sovvertire completamente il metodo d’insegnamento.
Come?
La domanda che ci arriva dalle nuove generazioni è molto evoluta, spazia dai temi ambientali alle dinamiche sociali, dalla dimensione smart a quella immateriale. Ci troviamo quindi di fronte a studenti con domande evolutissime e un’università che arranca.
Dalle facoltà oggi esce ancora una figura di architetto che poteva essere valida cinquant’anni fa, pensando ai costruttori. Oggi bisogna decostruire.
Città dei 15 minuti, se ne parla tanto, soprattutto nelle riflessioni sugli spazi post-Covid. Ma esistono davvero? C’è chi dice che in Italia esistono già.
In effetti in Italia le troviamo già nelle città medie, soprattutto in quella città media ideale, sempre in vetta alle classifiche sulla qualità della vita (secondo l’ultimo rapporto stilato da ItaliaOggi con l’Università La Sapienza di Roma, al primo posto nel 2021 c’è Parma, in quella del Sole 24 Ore in testa c’è Trieste, ndr). Ma la domanda è un’altra: perché questa metafora così semplice, ha toccato l’immaginario dei cittadini e della politica? Perché affonda in quel sogno che in ogni città si ritrovi la dimensione del villaggio e della comunità. Attenzione, non è una visione esclusivamente funzionalista, volta a trovare tutti i servizi vicino a casa, come la vuole semplificare la burocrazia. Tocca invece una corda profonda: la città del quarto d’ora risveglia il sogno della comunità, che con la pandemia ci siamo trovati a rimpiangere.
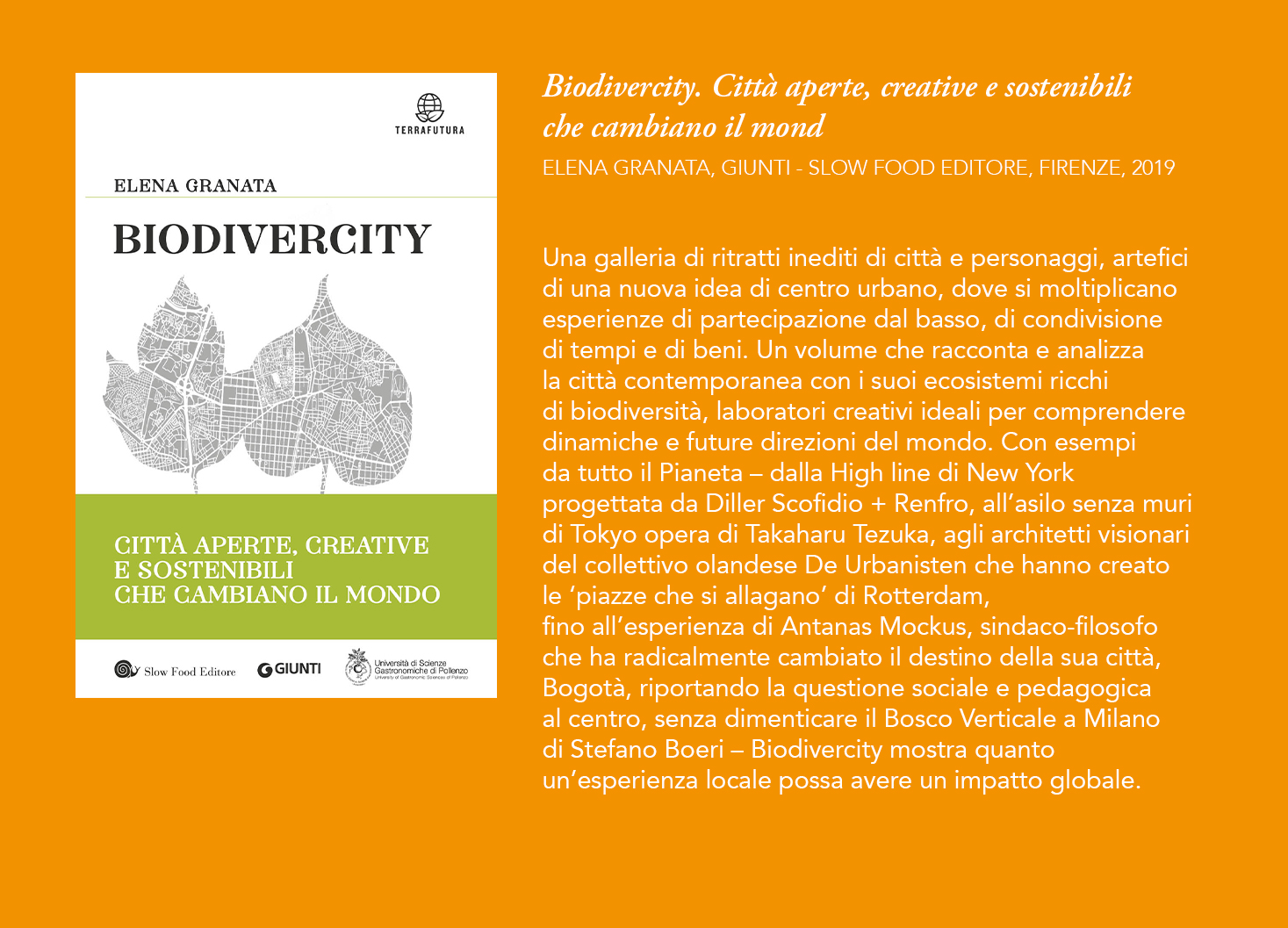
Scheda del libro Biodivercity di Elena Granata
Quali città quindi nel futuro? Servirà un nuovo patto tra cittadini, placemaker, progettisti e Pa?
Le città che hanno visto l’esito più felice, penso a Barcellona, Parigi, ma anche a Bogotà, sono quelle in cui c’è stato un grande attivismo dal basso, coniugato però ad una capacità di dare risposte dall’alto, nella costruzione di un vero patto. La mia sensazione è che in Italia il placemaker sia quello che fa animazione locale, l’urbanistica tattica, poi quando però si parla d’affari, entrano in campo altri protagonisti. Le città invece veramente metropolitane, che hanno compreso il ruolo della vera costruzione dei luoghi, considerano il placemaker come un attore fondamentale della strategia urbana. Da noi è una specie di ‘attivismo preparatorio’, a basso costo e di grande impatto sociale, affinché qualcuno poi faccia il grande investimento. Ma il patto deve ribaltare il gioco. Il placemaker è un attore strategico, economico e finanziario a tutti gli effetti.
Dal suo osservatorio, i fondi del Pnrr potranno contribuire effettivamente a rendere le nostre città più green?
Vedo lo stesso rischio anche nel Pnrr, perché va bene parlare della rigenerazione dei luoghi, ma poi ci sono le strategie immobiliari. La parte hardware delle città funziona secondo altre logiche, che sono quelle del real estate e della rendita, e non sono legate alla qualità di vita dei cittadini. Questo è un punto cruciale.
Attenzione quindi alla dimensione minuta della rigenerazione, alla qualità dell’aria, al sistema natura, forestazione, salute: non sono dei valori per anime belle, questi sono l’asset più importante delle città del futuro dal punto di vista strategico-economico. Lo dimostrano gli investimenti delle grandi capitali europee.
Lei è nella commissione Sherpa della Presidenza del Consiglio dei ministri per il G7/G20. Secondo lei, ci sarà un vero cambio di rotta per contrastare il cambiamento climatico?
Ho avuto la fortuna di partecipare all’organizzazione del G20 di Roma, nella costruzione dei contenuti del Governo italiano sui temi della sostenibilità in preparazione alla Cop26, vedendo un negoziato dal backstage. Sono processi molto freschi e recenti. Ed è qui che nasce la difficoltà nel valutarne gli esiti: è come un grande gioco, in cui ogni punto ci avvicina verso il risultato. L’esperienza umana profonda che ho fatto è di una missione impossibile nell’accordare paesi, culture, sensibilità, sofferenze così diverse in campo planetario. Tuttavia, nelle agende sono entrati, per esempio, i temi della sostenibilità e dell’empowerment femminile (si legga il contributo della ministra Elena Bonetti), cose che 5-10 anni fa sarebbero state impensabili. È un processo di apprendimento, i cui risultati non li possiamo quantificare in un “ce l’abbiamo fatta”. Paradossalmente abbiamo bisogno di portarci dietro tutti, un processo praticamente impossibile, ma non abbiamo altro gioco che questo, l’alternativa è la guerra.
I movimenti dal basso come quelli dei ragazzi dei Fridays for Future sapranno indirizzare le scelte della politica nella battaglia contro il cambiamento climatico?
In 3 anni abbiamo visto il movimento giovanile con più ragazze minorenni capaci di prendere voce per le loro nazioni e i loro popoli. Io ho anche fatto un piccolo check di tutte le ragazze, europee, indigene, africane, americane, tutte minorenni, tutte accomunate da questa efficacissima capacità di prendere la parola in pubblico, che non era delle donne. Non possiamo non riconoscere un talento di giovinezza e del femminile, ma questo è già accaduto! Hanno già smosso le agende e condizionato i negoziati. Ovvio che non basta, perché serve la responsabilità della politica, però non penso che la Cop26 sarebbe stata la stessa senza quella bambina che ogni giorno protestava seduta fuori dalla sua scuola.

Architettura architetturaChiECome arte città concorsi culto cultura energia festival formazione futura hospitality housing industria Ingegneria italiani all'estero legge architettura libri masterplanning Milano Norme norme e regole Premi Progettazione real estate Regole retail rigenerazione urbana salute scommessa roma Scuola sostenibilità spazi pubblici sport trasporti turismo uffici








